Unico l’uomo fra gli altri essenti esperimenta, chiamato dalla voce dell’essere, la meraviglia di tutte le meraviglie: che l’essente è.
(Heidegger, Poscritto a Che cos’è la metafisica)
Introduzione
È Platone, nel libro X della Repubblica, a raccontarci la straordinaria esperienza del persiano Er, valoroso figlio di Armenio, che trova la morte in guerra ma, “già deposto sulla pira, risuscitò e, risuscitato, prese a raccontare quello che aveva veduto nell’aldilà”. [Pl]
Er descrive allora un universo caratterizzato dagli elementi strutturanti l’episteme geocentrica: al centro del mondo, la Terra, sferica come sferico è il mondo stesso, governato dalla ineluttabilità della forza divina (“il fuso di Ananke, che faceva ruotare tutte le sfere”). Attorno a questo centro, l’eterna, perfetta rotazione delle sfere celesti. Come ben noto, Aristotele riprenderà, pur con modifiche, questa cosmologia sferica, che trova la sua più grandiosa sistemazione nell’Almagesto tolemaico, con cui si realizza l’aspirazione platonica all’idealità geometrizzante del cosmo. Questa stessa cosmologia geocentrica, introdotta nel basso Medioevo dal doctor angelicus Tommaso nel corpus dottrinario cattolico, informa grandiosamente il capolavoro dantesco.
Se già la fine del Medioevo assiste a un primo, timido cambiamento di prospettiva (pensiamo ad esempio a Nicola Oresme), sarà solo con l’avvento dell’Umanesimo (Cusano, che teorizza un universo di cui ogni punto è “centro”) e, successivamente, con il Rinascimento e oltre (Copernico, Keplero e Galileo, per citare i nomi più noti) che il processo di progressiva marginalizzazione della Terra a favore dell’ipotesi eliocentrica è messo a tema con progressiva convinzione. Con l’eccezione della grandiosa visione di Giordano Bruno (per il quale l’universo è infinito, privo di centro e popolato da innumerevoli mondi, ciascuno dotato degli elementi empedoclei: acqua, aria, terra e fuoco), l’uomo continua però a ritenere che il cosmo abbia ancora un centro, sia pure non più identificato con la Terra, ma con il Sole.
Occorre attendere il XVIII secolo e l’opera di Herschel per arrivare a riconoscere, correttamente, che le stelle osservate formano un gigantesco sistema stellare detto Via Lattea o Galassia. Sulla base di evidenze osservative sempre più numerose e dettagliate il Sole, non più “centro” di nulla, finisce così anch’esso per perdere il suo status privilegiato: l’uomo deve prendere atto che la nostra stella è una delle tante, occupante una posizione del tutto periferica, ai margini della Galassia.
Saranno infine gli anni Venti del XX secolo ad assistere all’ulteriore passo, annunciato da Hubble il 30 dicembre 1924: infatti, l’analisi dei dati dimostra definitivamente che la “nebulosa di Andromeda” è con certezza un oggetto extragalattico, ponendo così fine a un’annosa diatriba scientifica. Si tratta del decisivo riconoscimento che le molte “nebulose” in precedenza osservate sono a loro volta sistemi stellari (galassie), simili per struttura e dimensioni alla Via Lattea ma situati a enormi distanze da questa. Oggi si stima che il numero di galassie dell’universo sia dell’ordine di mille miliardi [CWDM] (di cui solo il 10% direttamente osservabile), ciascuna costituita da un numero di stelle dell’ordine del centinaio di miliardi.
Il processo, al tempo stesso culturale e scientifico, qui brevemente delineato attesta la progressiva e ineluttabile marginalizzazione dell’uomo, per quanto attiene alla sua collocazione fisica nell’universo. L’essere umano continua tuttavia ad occupare una posizione di assoluta centralità sotto un diverso cono visuale: l’uomo rappresenta infatti l’unica forma di vita ad oggi nota che, dotata di intelligenza, sia capace di problematizzare l’origine del cosmo, la sua struttura e il suo destino, nonché di porsi interrogativi esistenziali sul senso del nascere, del vivere e del morire.
Se anzi attribuiamo al termine cosmologia il significato di visione unitaria della totalità della natura, possiamo dire che è proprio la cosmologia a tenere a battesimo le prime manifestazioni della civiltà umana.
La grandiosa maestosità dello spettacolo celeste, infatti, ha certamente costituito un potente stimolo al riconoscimento del carattere sacrale di una natura che scandisce il tempo del terrestre mortale: alla perenne ricerca di un senso unitario e divino del mondo in grado di trascendere la precarietà della sua esistenza, l’uomo comincia a pensare al “rimedio” capace di garantirlo dalla prospettiva dell’annientamento. Così, il pensiero ha cominciato a essere teologico, filosofico e scientifico proprio in quanto esso fu originariamente cosmologico: non a caso tra le scienze antiche è stato proprio lo studio del cielo a raggiungere lo stadio di maggiore perfezione, arrivando a offrire il primo modello di una “scienza della natura”.
L’osservazione del cielo stellato, di fronte al quale il leopardiano pastore errante si riempie di stupore (lo stesso thauma – “meraviglia”, ma anche “paura” – dal quale origina, secondo Aristotele, l’interrogazione filosofica di fronte al mistero del mondo) pone allora in modo del tutto naturale la “grande questione”: l’universo ospita altre forme di intelligenza, oltre quella umana?
La risposta, come ben si comprende, è potenzialmente capace di privare l’uomo dell’ultimo privilegio di centralità rimastogli: interrogativo tanto complesso quanto affascinante, che la scoperta di pianeti extrasolari (esopianeti), avvenuta negli anni Novanta del secolo scorso, ripropone con forza all’attenzione della comunità scientifica e, più in generale, dell’opinione pubblica.
Risulta infatti di tutta evidenza che la possibilità di sviluppo della vita e, in particolare, di eventuali forme di vita intelligente, richiede per necessità che siano disponibili “oggetti planetari” con determinate e “opportune” caratteristiche chimico-fisiche. La conferma sperimentale di quella che fino ad allora aveva costituito solo un’ipotesi, per quanto ragionevole, non ha dunque mancato di suscitare clamore e interesse.
Ma quali sono le ragioni che, rendendo tanto difficile l’osservazione di esopianeti, l’hanno tanto a lungo ritardata? E quali le tecniche osservative cui gli astrofisici fanno ricorso? Quali le caratteristiche di questi oggetti così a lungo ricercati?
Ai prossimi paragrafi il compito di abbozzare una risposta.
Fine parte 1a di 4 – segue..
Bibliografia:
- [As] Asimov I., Civiltà extraterrestri, Mondadori, Milano (1986)
- [BT] Barrow J.D., Tipler F.J., Il principio antropico, Adelphi, Milano (2002)
- [Co] Covone G., Altre Terre, HarperCollins, Milano (2023)
- [CWDM] Conselice C.J, Wilkinson A., Duncan K., Mortlock A., The Evolution of Galaxy Number Density at z < 8 and its Implications, https://arxiv.org/abs/1607.03909v2 (2016)
- [He] Heidegger M., Essere e tempo, Longanesi, Milano (2005)
- [Ho] Howard A.W., Observed Properties of Extrasolar Planets, Science, 340, 572-576 (2013) DOI: 10.1126/science.1233545
- [MAR] Mahima K., Aditee M., Ritesh R., Exoplanet Detection: A Detailed Analysis, arxiv:2404.09143v2 (2024)
- [NEA] Nasa Exoplanet Archive, https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/
- [PHM] Petigura E.A, Howard A.W., Marcy G.W., Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 110, n. 48, 31 ottobre 2013, pp. 19273–19278 DOI:10.1073/pnas.1319909110.
- [Pl] Platone, Repubblica, libro X, Mondadori, Milano (2008)
- [We] Wenda C., The Comparison of Five Methods of Detecting Exoplanets. Highlights in Science, Engineering and Technology, 38, 235-244 (2023). DOI:10.54097/hset.v38i.5812
Autore: Ivan Cervesato




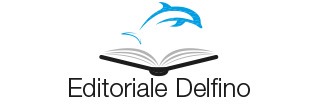
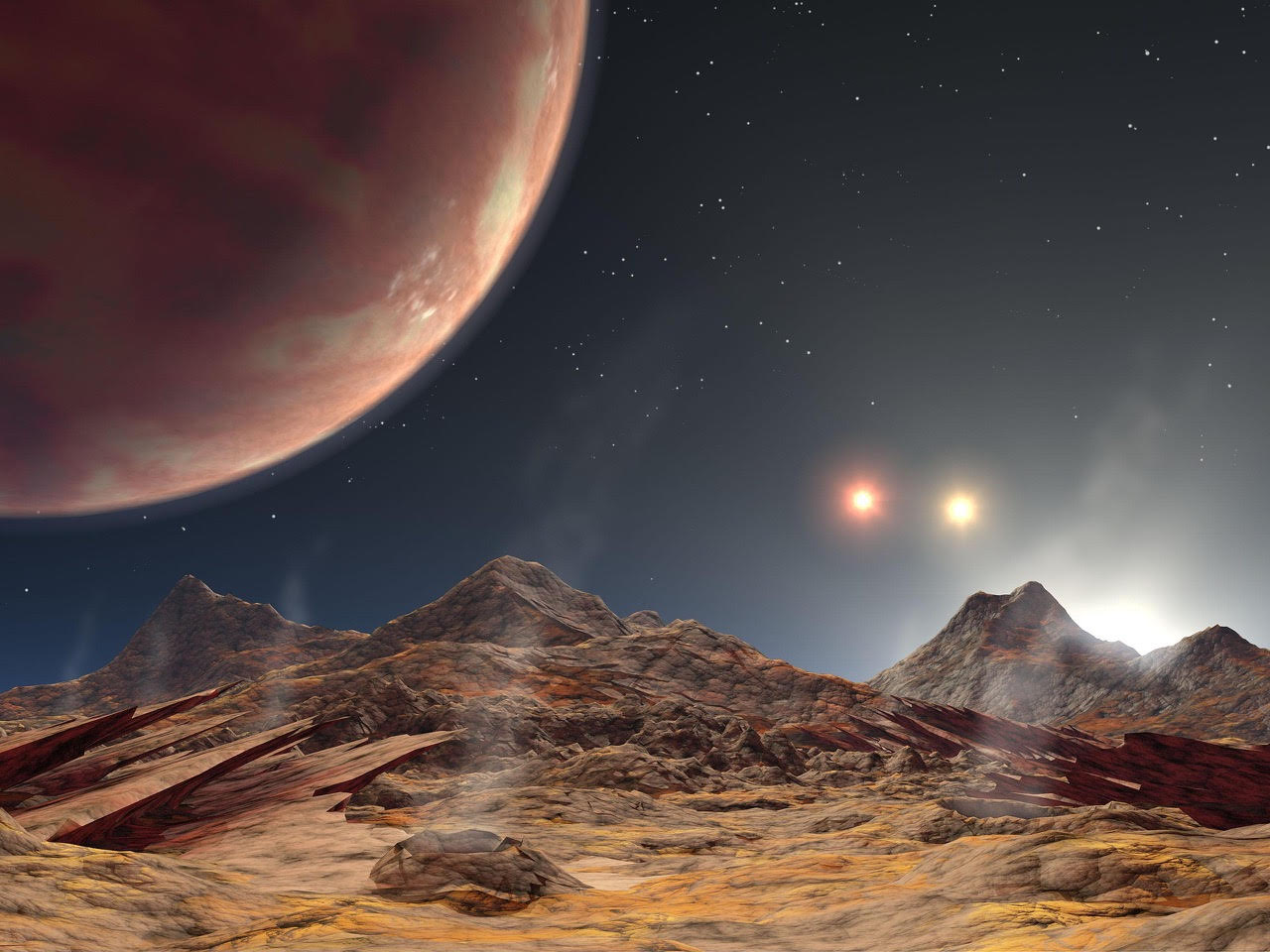
0 commenti