6.2. Cambiamenti culturali: Umanesimo e Naturalismo
PARTE PRIMA: L’UMANESIMO
Grazie alla rinascita economica, sociale, politica ed urbana, di cui abbiamo detto nella scorsa puntata, si rende possibile in Europa anche una rinascita culturale: quella delle arti, delle lettere e delle scienze.
La cultura rinascimentale ha due grandi fasi: la prima va dalla seconda metà del ‘300 a tutto il ‘400 ed è prevalentemente umanistica, la seconda si sviluppa nel ‘500 ed è prevalentemente naturalistico-scientifica.
“Umanesimo” significa innanzitutto centralità dell’uomo, antropocentrismo.
Se nella cultura medioevale erano predominanti le divinae litterae, le discipline teologiche, ora vengono in primo piano le humanae litterae, o studia humanitatis, cioè le discipline concernenti l’uomo (o, appunto, “umanistiche”): la storia, la letteratura, la filologia, l’etica…
Come modelli ideali da emulare (è il principio della imitatio, che non significa imitazione passiva, ma piuttosto “emulazione”) si prendono gli scrittori classici latini e greci. Si sente il bisogno di rileggerne approfonditamente le opere nella versione originale; di qui l’importanza della filologia (lo studio e la ricostruzione dei testi classici).
Perciò è corretto dire che se il Rinascimento è un periodo storico che fa da ponte tra il medioevo e l’età moderna, l’Umanesimo è una delle sue manifestazioni nell’ambito della cultura.
Gli umanisti pongono dunque l’uomo al centro dell’universo e lo vedono, anzi, come specchio e miniatura dello stesso per l’ordine e l’armonia che regnano tra le parti dell’uno come dell’altro. “Microcosmo nel macrocosmo” (“piccolo universo nel grande universo”) è la celebre espressione che meglio rappresenta tale rapporto.
Un esempio tipico della produzione umanistica è costituito dalla famosa orazione di Pico della Mirandola dal titolo De hominis dignitate (“La dignità dell’uomo”). L’autore, noto per la sua cultura enciclopedica e per la sua memoria prodigiosa, immagina che il divino creatore, una volta giunto al culmine della sua immensa opera con la creazione dell’uomo, gli abbia detto di non avere un posto fisso da assegnargli nell’universo, come aveva fatto invece per tutte le altre creature. Il divino Artefice volle che l’uomo, a differenza di tutti gli altri enti, potesse autodeterminarsi liberamente e lo pose al centro del creato perché a lui solo spettassero la scelta e la responsabilità di abbassarsi al livello dei bruti o di elevarsi a quello delle intelligenze angeliche.
In altre parole, il libero arbitrio fu il grande ed esclusivo dono riservato da Dio alla più nobile delle sue creature. Gli umanisti ritengono infatti che l’uomo possa e debba essere artifex fortunae suae (“artefice della propria sorte”). Nel fare ciò, nel creare sé stesso ed il proprio mondo, egli si avvicina al Creatore per antonomasia, a Dio; e questo è un altro tratto distintivo della cultura umanistica: il riavvicinamento tra uomo e Dio.
La cultura religiosa medioevale era caratterizzata da un’immensa distanza tra l’uno e l’altro. Dalla parte del creatore era collocato tutto ciò che vi è di bello, di nobile e di positivo; dalla parte della creatura tutto quanto vi è di corrotto, di debole, di imperfetto. Ben rare erano le eccezioni: una tra tutte è rappresentata da San Francesco (vedi appunto il suo Cantico delle creature), il quale tuttavia vive ed opera nell’ambito di quella fase che, se non si può ancora chiamare “Rinascimento” in senso stretto, si può comunque già definire di “rinascita” in senso lato.
Ora invece, grazie alla sua autodeterminazione ed alla sua creatività, l’uomo si riavvicina a Dio ed è visto anzi come immagine ed emulo del suo creatore. Ecco perché la cultura umanistico-rinascimentale esalta tutte le figure particolarmente creative, come quelle dell’artista, dello scienziato, dell’inventore. Per queste ragioni possiamo dire che una delle figure più emblematiche di tale cultura è quella di Leonardo da Vinci, così come pure l’immagine del suo “Uomo vitruviano”, diventata simbolo stesso dell’antropocentrismo rinascimentale.
PARTE SECONDA: IL NATURALISMO (DALLA MAGIA ALLA SCIENZA)
Come il medioevo aveva divaricato le posizioni dell’uomo e di Dio, così aveva fatto tra il mondo naturale e quello soprannaturale ed il primo aveva finito per essere relegato nell’ambito di quanto vi è di corrotto, di spregevole, di peccaminoso.
Come invece l’età rinascimentale emancipa e rivaluta il ruolo dell’uomo, altrettanto fa con quello della natura. Essa è vista ora come segno ed immagine tangibile della grandezza e della potenza divine. È la dimora dell’uomo e come tale è degna di essere curata, studiata, ammirata. Pensiamo, a mo’ d’ esempio, a quella tipica sintesi tra creatività umana e bellezza della natura che è rappresentata dal giardino rinascimentale. Esso, nel suo ordine e nella sua armonia, è la celebrazione stessa dell’una e dell’altra ed il frutto medesimo della collaborazione tra uomo e natura.
Un’altra tipica manifestazione del loro stretto rapporto è costituita dalla magia. Tanto per spazzare il terreno da possibili equivoci chiariamo subito che la magia rinascimentale nulla ha a che fare con amuleti, maledizioni, incantesimi ed altre ciarlatanerie di tal genere. Essa è piuttosto la ricerca dell’armonia con sé stessi, con gli altri e soprattutto con la natura.
Uno degli esempi più fulgidi della figura di mago rinascimentale è rappresentato da Filippo Giordano Bruno. Nato a Nola (NA) nel 1548, fin da giovanissimo egli manifesta la sua vocazione per il divino entrando a soli quindici anni nell’ordine dei domenicani e prendendo l’abito ai diciotto. Il suo spirito irrequieto e la sua inesausta sete di conoscenza lo portano a viaggiare per tutta l’Europa e a conoscere sovrani come Enrico III di Valois in Francia ed Elisabetta I in Inghilterra. Poi un sedicente amico, il nobile Giovanni Mocenigo, lo ospita a Venezia ma lo tradisce denunciandolo come eretico al Tribunale dell’Inquisizione. Seguono otto anni di processo, di carcere duro e, molto probabilmente, di torture. Bruno, invitato ad abiurare, resta fermo sulle sue posizioni. Nel gennaio del 1600 arriva la condanna, alla quale egli risponde con parole divenute celebri: “Forse tremate di più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell’ascoltarla”. Il diciassette febbraio Bruno muore sul rogo, a Roma, in piazza Campo de’ Fiori.
Ma quali sono i motivi che fanno apparire tanto pericolosa la filosofia bruniana agli occhi dei suoi persecutori? Bruno ha una visione decisamente panteistica; concepisce una natura viva e divinizzata. Precorrendo Spinoza egli afferma che Dio è la natura, è l’intero universo. L’empito religioso che spinge Bruno fin da giovane a cercare la fusione con Dio si traduce pertanto in uno slancio di fusione con l’universo intero e con tutti gli altri esseri viventi che ne sono figli.
In un’epoca caratterizzata da sanguinosi conflitti religiosi (il Cinquecento è il secolo della Riforma e della Controriforma) il filosofo nolano concepisce come risposta un universo unitario ed armonico. Lo strumento principe per realizzare tale unità e tale fusione è la magia, vista come una serie di tecniche (per esempio di concentrazione e di meditazione) volte ad ampliare le facoltà ed i confini della mente umana fino a consentirle di abbracciare tutte le altre menti e l’intero universo.
La visione bruniana del cosmo, seppur su basi magiche e non scientifiche, si spinge ben oltre la rivoluzione eliocentrica di Copernico. Il nolano concepisce infatti un universo infinito e libero, non più ingabbiato nelle “sfere celesti” di aristotelica memoria, alla cui esistenza l’astronomo polacco crede ancora.
A sua volta il filosofo e politico inglese Francis Bacon (italianizzato: Francesco Bacone) ha almeno due grandi meriti. Il primo consiste nell’aver intuito l’importanza della scienza e della tecnica per la società moderna (“il filosofo dell’età industriale” è il titolo che gli studiosi gli hanno attribuito); il secondo sta nell’aver compreso l’importante ruolo del “metodo” per la scienza. Egli scrive infatti una celebre opera dal titolo Novum organum (“Il nuovo metodo”) in contrapposizione con il metodo tradizionale, rappresentato dalla logica aristotelica (L’Organon o Organum).
Secondo Bacon il classico procedimento sillogistico-deduttivo di Aristotele (“Tutti gli uomini sono mortali – Socrate è un uomo – Quindi Socrate è mortale”) è un procedimento sterile in quanto non aggiunge nulla di nuovo al nostro sapere. Infatti, la conclusione secondo la quale Socrate è mortale è già implicita nella premessa per cui tutti gli uomini sono mortali.
Pertanto, Bacon propone di sostituire al metodo deduttivo (che procede dall’universale al particolare) un metodo induttivo (che procede dal particolare all’universale) che parta dalla raccolta di dati e giunga, attraverso la loro elaborazione, alla formulazione di una “legge” scientifica generale.
Interessante è che per il filosofo inglese il nuovo metodo deve sintetizzare l’attitudine empiristica consistente nella raccolta di dati con quella razionalistica consistente nelle loro elaborazioni. Bacon paragona infatti l’attitudine dello scienziato moderno a quella delle api, che raccolgono il polline e lo elaborano per trasformarlo in miele; mentre gli empiristi assomiglierebbero alle formiche, che accumulano senza elaborare a sufficienza, ed i razionalisti assomiglierebbero ai ragni, che ricavano da sé stessi la loro tela (nella similitudine la conoscenza).
Altrettanto notevole è l’importanza del ruolo della sperimentazione e della verifica in tutto il procedimento. Il metodo baconiano è rigoroso ed attento a verificare nella pratica le ipotesi dello scienziato.
I fattori fin qui individuati costituiscono la “faccia moderna” di Bacon; ma egli è una sorta di “Giano bifronte”. Se guardiamo allo scopo, all’esito finale a cui dovrebbe approdare secondo lui la ricerca scientifica, scopriamo che quando parla della “legge” da individuare egli intende la “natura” del fenomeno studiato, la sua “essenza”: qualcosa di nient’affatto lontano dalla ipsissima res (“la cosa stessa”) di Aristotele e della Scolastica. Quest’altra è la “faccia tradizionale” di Bacon, quella che insieme alla prima fa di lui un’erma bifronte che guarda da un lato al futuro ma dall’altro anche al passato.
Esattamente per tali ragioni egli è da considerarsi l’ultimo grande pensatore del Rinascimento più che il primo dell’età moderna. Colui che, al contrario di Bacon, rappresenta il passaggio dalla cultura rinascimentale alla scienza moderna, colui che rappresenta la rivoluzione scientifica vera e propria, è Galileo Galilei.
Galileo condivide con Bacon la convinzione dell’importanza del metodo e della sperimentazione per la scienza moderna. Concorda anche sulla necessità della componente empiristica (le “sensate esperienze”, cioè quelle basate sui sensi e in particolare sull’osservazione) come di quella razionalistica (le “certe dimostrazioni”). Ma vi aggiunge un elemento essenziale del tutto assente nel pensatore inglese: la matematica.
La ricerca baconiana è elettivamente ed esclusivamente qualitativa; punta come detto alla “natura”, all’”essenza”, insomma alla “qualità” dei fenomeni studiati. Galileo invece sottolinea come indispensabili la misurazione, il calcolo, la formulazione delle leggi scientifiche in termini matematici.
Nella celebre opera Il Saggiatore egli afferma senza mezzi termini: “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola”.
Oltre ed insieme alla centralità attribuita alla matematica, la grande rivoluzione operata da Galileo non consiste poi nella presunta “invenzione” del cannocchiale (probabilmente realizzato già prima in Olanda), ma piuttosto nell’uso fattone puntandolo verso il cielo per studiare, grazie all’osservazione, quell’astronomia, che prima veniva invece studiata sui libri, in particolare sulla Fisica di Aristotele.
PARTE TERZA: CONCLUSIONI (PROVVISORIE)
Siamo giunti al termine di questa (prima?) serie di articoli dedicati al “cammino della verità” e ci corre pertanto l’obbligo di trarre alcune conclusioni, come sempre del tutto parziali e provvisorie.
La “rivoluzione scientifica” non sarebbe stata possibile senza i profondi cambiamenti sociali e culturali di cui abbiamo detto nell’articolo precedente. Ciò dimostra ancora una volta come il “cammino della verità” sia un grande, complesso e multiforme processo storico che coinvolge le esistenze di generazioni su generazioni. Parte integrante di questo cammino è costituita da un altro grande processo o cammino, che è quello della conoscenza, attraverso il quale noi esseri umani cerchiamo di prendere “dall’interno” coscienza di noi stessi e del mondo di cui siamo parte attiva, dei suoi movimenti e della sua vita.
È dunque più corretto parlare della verità o delle verità? Verrebbe da dire “Ai posteri l’ardua sentenza”. Ma sarebbe un modo per cavarsela un po’ troppo sbrigativamente. Tutte le considerazioni fin qui svolte ci consentono quanto meno di ritenere che la verità non possa essere solo una, e soprattutto non possa essere considerata universale, assoluta e definitiva. Affermare ciò sarebbe insieme causa ed effetto di una visione del mondo tanto presuntuosa quanto obsoleta.
Al tempo stesso occorre cautela nell’azzardare risposte alternative. Potremmo allora dire che la verità include diversi rami o diversi affluenti che tuttavia si riuniscono talvolta in un corso unitario per poi diramarsi e differenziarsi nuovamente. Forse proprio nell’immagine di questa concordia discors, di questa armonia polifonica e polivocale in continuo divenire, possiamo trovare il nucleo vitale di una nuova concezione della verità all’altezza dei nostri tempi.
Leggi anche
Il cammino della verità – 6 L’età rinascimentale
Autore: Roberto Maria Pittella




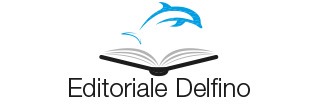
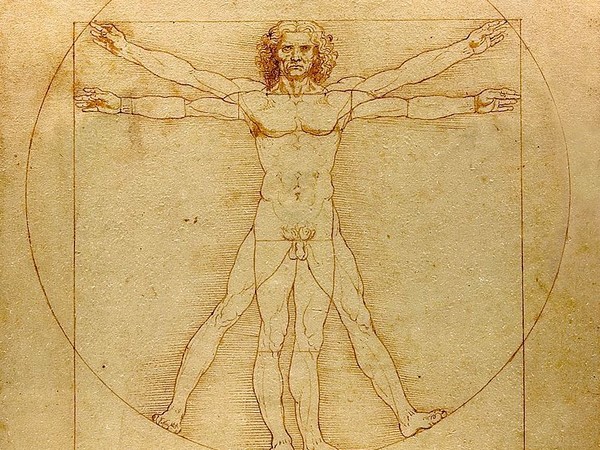
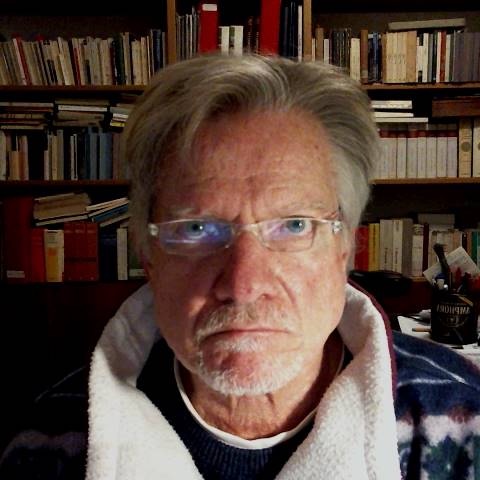
0 commenti