Tra realtà e suggestioni nella Discesa di Cristo al Limbo
Il grande dipinto su tavola centinata della Discesa di Cristo al Limbo, conservato presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, è una celebre opera di Beccafumi; denso di significati simbolici è un capolavoro che dimostra la grande abilità dell’autore nel trattare temi complessi.
L’impostazione iconografica, come è noto, trae ispirazione dal vangelo apocrifo di Nicodemo. Il Limbo è rappresentato dall’artista come un antro oscuro all’inizio dell’Inferno, dove, in alto, la figura del Battista annuncia l’entrata del Cristo, venuto a liberare tutte le anime dei patriarchi, dei profeti, dei martiri. Infatti Cristo irrompe vittorioso, abbattendo la porta degli inferi che cade sopra il corpo di Satana, seguito dal buon ladrone che tiene in mano la corda e la croce a cui era legato. Il ladrone è dipinto con le gambe spezzate, l’autore con pochi tratti di colore ha evidenziato gli ematomi scuri, mentre dalle ferite scendono gocce di sangue rese con colpi di luce che conferiscono la tridimensionalità. Questo particolare, visibile solo a un’osservazione ravvicinata, risulta molto toccante grazie alla straordinaria maestria dell’esecuzione.
Cristo tende la mano al vecchio Adamo, aiutandolo ad alzarsi, e sarà il primo uomo a essere liberato. Accanto a lui è ritratto il re David, riconoscibile dalla corona e dalla lira a nove corde. Questo numero interessante ci rimanda alla lira di Orfeo: inizialmente dotata da Apollo di sette corde, lo strumento venne modificato da Orfeo con l’aggiunta di altre due corde. Tuttavia, nella rappresentazione di David, la lira assume un significato simbolico, poiché evoca, attraverso la musica, l’arte e la lode, la connessione profonda con Dio.
A destra del dipinto si trova Eva, forse il ritratto di una Piccolomini, invece il personaggio disteso in basso con il grande pesce è sicuramente Giona. Infine, a sinistra, sotto il corpo di Satana, si apre la bocca dell’Inferno, da cui si levano filamenti di fumo.

Figura 1. La Discesa di Cristo al Limbo. Beccafumi
Nel 2007 ci siamo dedicati al restauro conservativo dell’opera. Durante i primi interventi, mentre utilizzavamo un ponteggio mobile,

Figura 2. Restauro manutentivo del 2007 della Discesa di Cristo al Limbo nella Pinacoteca Nazionale di Siena
ci siamo accorti, osservando il dipinto da vicino, della presenza, in alto, a destra, di disegni antropomorfi delle rocce, che sovrastano l’antro del Limbo, che assomigliano a volti e figure ma che dal basso a prima vista non si notano bene.

Figura 3. Particolare delle rocce, a destra, in alto
SIncuriositi da quello che vedevamo, abbiamo effettuato diverse riprese fotografiche che hanno rivelato un volto con occhi, naso prominente, bocca e mento, un’immagine che ci ha immediatamente ricordato il profilo di Dante Alighieri, raffigurato in diverse opere già dall’inizio del Trecento. Accanto a questo volto, apparentemente ben dissimulato, seppur difficile da interpretare con certezza, appare un altro volto, con occhi e bocca appena accennati. Se effettivamente si trattasse di un secondo volto, non potrebbe che essere quello di Virgilio, poiché, essendo vissuto prima del Battesimo, Dante lo colloca nel Limbo, il luogo che descrive nell’Inferno della Divina Commedia .

Figura 4. Le rocce con i volti di profilo, quello a destra è stato evidenziato per una migliore lettura
Questi due personaggi, una sorta di convitati di pietra ante litteram, posti forse a firma dell’Inferno a cui hanno dato vita nelle loro opere, sembrano osservare la scena sottostante e contemporaneamente guardare una strana e inquietante colonna di pietra, frutto della fusione di una stalattite e una stalagmite. Questa colonna presenta caratteristiche antropomorfe sorprendenti: osservando bene, sembra di riconoscere un uomo nudo, in piedi, con il ginocchio destro piegato e il ventre ben delineato. Le braccia, distese verso l’alto, mostrano le ascelle, mentre, al centro, pare d’intravedere o si può immaginare un volto pietrificato che urla per l’orrore di essere imprigionato per l’eternità. Un’immagine suggestiva che ci ricorda proprio l’Urlo di Munch e il suo profondo significato esistenziale.

Figura 5. A sinistra, l’Urlo di Munch, 1893. A destra, particolare della ‘colonna’ nella Discesa di Cristo al Limbo di Beccafumi del 1536. L’accostamento delle immagini è molto affascinante, una suggestione che anticiperebbe di oltre tre secoli e mezzo quella di Munch
Si potrebbe fare un riferimento dantesco al Canto XIII dell’Inferno dove i suicidi sono trasformati in piante per aver rinunciato alla loro condizione umana.

Figura 6. Part. Incisione di G. Doré. I suicidi nel Canto XIII dell’Infermo
Un ulteriore accostamento iconografico, sempre ammettendo il carattere antropomorfo che per il momento abbiamo assegnato alla ‘colonna’, potrebbe essere quello che ritrae i Prigioni non finiti di Michelangelo a Firenze.

Figura 7. La ‘colonna’ antropomorfa nella Discesa di Cristo al Limbo
Anche se Beccafumi probabilmente non li conobbe, entrambi i lavori condividono solo una certa similitudine formale.

Figura 8. Prigione di Michelangelo
Per quanto riguarda l’idea della ‘colonna’, un’ipotesi probabile è quella che Beccafumi abbia tratto spunto dalle Metamorfosi di Ovidio, testo che conosceva bene, in quanto durante la sua produzione artistica più volte ne ha illustrato alcuni episodi, come il mito di Decaulione e Pirra. Ma tra tutte le trasformazioni di uomini in pietre, descritte nelle Metamorfosi, ci viene in mente il racconto dove Perseo sconfigge Fineo, il pretendente di Andromeda, utilizzando la testa di Medusa per pietrificarlo: “Così disse, e nella direzione in cui aveva Fineo sgomento spinto il suo viso, spostò la testa della figlia di Forco [Medusa]. Anche allora egli cercò di rivolgere altrove lo sguardo: il collo s’irrigidì, le sue lacrime si fecero di pietra; e nel marmo rimasero fissati un’espressione di terrore … ”. In questa scena, il passaggio dalla vita alla pietra è descritto in modo drammatico, come una trasformazione che non solo coinvolge il corpo, ma anche le emozioni, intrappolando l’espressione del terrore in un blocco eterno, che potrebbe aver ispirato la figura della ‘colonna’ come simbolo di immobilità e pietrificazione.
Arrivati a questo punto, era fondamentale fornire prove scientifiche a sostegno delle nostre osservazioni.
Ci siamo quindi posti l’obiettivo di indagare il disegno preparatorio utilizzando una macchina riflettografica ad alta risoluzione, ma per la mancanza di fondi abbiamo dovuto attendere quindici anni per l’occasione giusta.
Nel 2022, eravamo nuovamente impegnati nella Pinacoteca di Siena per il restauro di opere di Beccafumi, quando ci siamo ricordati della nostra intenzione di indagare la Discesa di Cristo al Limbo. Avevamo recentemente condotto indagini diagnostiche IR con il collega Thierry Radelet su altri dipinti, utilizzando l’attrezzatura ideale per il nostro progetto. Radelet si è subito reso disponibile, così come il Direttore Axel Hémery della Pinacoteca, che ci ha dato tutta la collaborazione necessaria, per questo li ringraziamo entrambi.
Le riprese infrarosse sono state eseguite tra i 1500 e i 1700 nm su tutta l’opera ad eccezione della sola parte centinata.

Figura 9. Durante le riprese IR all’interno della Pinacoteca Nazionale di Siena
I risultati sono stati straordinari, rivelando una quantità sorprendente di disegni, molti dei quali privi di corrispondenza con la parte pittorica. Nel nostro caso presenteremo solo quelli pertinenti alle tesi sopra esposte, perché vogliamo lasciare nei modi e nei tempi la futura divulgazione dell’intera ricerca alla discrezione del Direttore A. Hémery.
La prima verifica effettuata sulle immagini infrarosse ha riguardato la presenza del disegno del volto che abbiamo attribuito a Dante. Questo è apparso ancora più evidente della raffigurazione pittorica, soprattutto è risultato chiaro il disegno dell’occhio.

Figura 10. Immagine IR del volto di profilo di “Dante”

Figura 11. Idem. Particolare IR che mostra il disegno dell’occhio
L’analisi infrarossa della ‘colonna’ invece ha rivelato un abbozzo di figura con una vistosa pancia, caratterizzata da un ombelico ben definito, questo particolare risulta incoerente con l’idea di una stalattite o stalagmite, ma pertinente a quella di una figura umana.

Figura 12. Particolare IR della ‘colonna’
Considerando la presenza del disegno preparatorio, che inoltre non ha subito in questa zona modifiche a differenza di tante altre figure che sono state in parte ridisegnate, ne consegue che tale rappresentazione non sia frutto di un’esecuzione estemporanea, ma di una concezione pensata fin dall’inizio dell’opera.
Un’altra scoperta, che si potrebbe ricollegare al volto presunto di Dante, è la testa di un demone che emerge dalla bocca dell’Inferno, disegnata da Beccafumi ma non tradotta nella pittura. Questo diavolo, disturbato dal tumulto e dall’abbattimento della porta da parte di Cristo, si affaccia per osservare cosa stia accadendo. Visibilmente adirato, lancia sguardi infuocati al collega che non è riuscito a mantenere chiusa la porta, ora rovinata. Questa scena può essere ricondotta ancora al vangelo di Nicodemo nell’alterco tra Satana e l’Ade per aver attirato il Cristo nell’Inferno, ma può anche evocare un episodio del Canto XXII dell’Inferno di Dante, in cui due diavoli alati, Alichino e Calcabrina, si trovano in una situazione simile: Alichino viene ingannato da un dannato, suscitando l’ira di Calcabrina che vuole azzuffarlo.

Figura 13. Particolare della bocca dell’Inferno in basso a sinistra del dipinto

Figura 14. Idem, in basso a destra nell’ immagine IR è apparsa la testa disegnata di un demone

Figura 15. Macrofotografia IR del bellissimo disegno di un demone che però Beccafumi non ha tradotto in pittura
Dallo studio e dal confronto delle immagini acquisite nel visibile e nell’infrarosso potrebbe emergere l’ipotesi che Beccafumi ha voluto celare nel dipinto un tributo sia a Ovidio sia a Dante. È però fondamentale considerare che questi dettagli nell’intenzione dell’artista non devono apparire ad una facile lettura, certamente non devono risultare immediatamente evidenti. È probabile che per questo motivo abbia scelto di non rappresentare il secondo diavolo. Anche Vasari, che osservò il dipinto, rimase colpito dall’insolito scenario, nelle “Le vite” riporta infatti: « … dentrovi Cristo che scende glorioso al limbo a trarne i Santi Padri, dove tra molti nudi è una Eva bellissima; et un ladrone, che è dietro al Cristo con la croce, è figura molto ben condotta; e la grotta del limbo et i demonii e fuochi di quel luogo sono bizzarri affatto».
Non abbiamo altro da aggiungere, forse le nostre sono soltanto suggestioni e Beccafumi ha dipinto solo delle semplici pietre. Lasciamo pertanto al lettore il giudizio finale.
Autori: Nadia Presenti¬, Mario Verdelli




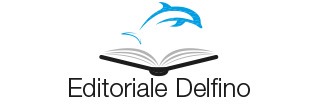



0 commenti