Dedicato:
A Salvatore Furia, astronomo carismatico e fondatore dell’Osservatorio del Campo dei Fiori, dove chi scrive osservò stelle doppie, anelli di Saturno, le luci di piazzale Loreto con il cannocchiale già di Mussolini, e scrisse la sua tesi sulla turbolenza omogenea. E al relatore di tale tesi, Carlo Cercignani, la cui attività di ricerca non fu fermata nemmeno da lunghi anni con sclerosi a placche.
1. INTRODUZIONE
In due lezioni tenute nel 1587, Circa la figura, sito e grandezza dell’Inferno di Dante, il giovane Galileo ventitreenne studiò la struttura geografica dell’inferno dantesco, arrivando ad una conclusione sull’altezza di Lucifero. L’inferno in Dante è un cono rovesciato, pari in volume a un dodicesimo del volume terrestre. Il vertice del cono è al centro della Terra, dove si trova Lucifero, confinato in una “ghiaccia”. Di Lucifero, usando informazioni in Dante, stima l’altezza a 1935 braccia, ovvero circa 1200 metri.
Lo studio di Galileo è stato nell’autunno del 2018 rivisitato in due fascinose conferenze a Milano presso l’associazione SATOR, fondata dal fisico Cesare Oliva. Cesare fu collega di studi universitari di questo autore, che ricorda le appassionate conversazioni giovanili su temi astronomici, nonché una notte all’Osservatorio del Campo dei Fiori, sopra Varese. Vi giungemmo con la mia Citroen Dyane 6 dopo aver attraversato la pianura fra Milano e Varese immersa nella nebbia. Sugli 800 metri di altezza, uscimmo dalla nebbia per contemplare a sud un ondulato mare di nubi illuminate dalla Luna e a nord le Alpi dominate dalla piramide del Finsteraahron, 4276 m. Nelle conferenze SATOR, Cesare Oliva e il pianista Alberto Aldrighi, hanno approfondita l’analisi di Galileo sull’inferno dantesco, evidenziando la complessità e la ricchezza dello scenario geografico ed astronomico di Dante.
In questo lavoro prima diamo alcune considerazioni sulla geografia infernale dantesca, che portano ad un interessante problema anche per altri campi, non trattabile in modo semplice. Poi consideriamo la questione dell’altezza di Lucifero, dando al valore calcolato da Galileo un ulteriore significato, da cui deriva una altezza di Lucifero più accettabile in quanto simile ad altezze ricavabili in altri contesti. Contesto che può aprire, ma non è compito di questo articolo, considerazioni circa il possibile arrivo sulla Terra di esseri intelligenti da altre parti del sistema solare, senza doverle cercare in sistemi planetari extra solari.
2. NOTE SULLA GEOGRAFIA DELL’INFERNO DANTESCO
Dante presenta l’inferno come un cono rovesciato, nel cui vertice al centro della Terra è collocato Lucifero; i gironi sono terrazzamenti agganciati alle pareti del cono, la copertura del cono è parte della crosta terrestre. Dante entra nell’inferno con Virgilio da un ingresso vicino a Cuma, in Campania. In merito a tale scenario sono di interesse le seguenti note.
La zona di Cuma, nella regione vulcanica campana dei Campi Flegrei, presso Pozzuoli, a una ventina di km ad ovest del centro di Napoli, ha una speciale interesse geologico, per il pericolo di una enorme esplosione vulcanica. In tale zona si trova il complesso sotterraneo della Sibilla Cumana. Le Sibille erano sacerdotesse, presenti probabilmente in varie parti d’Italia, si ricordino i Monti Sibillini fra Norcia ed Ascoli Piceno, e attive in riti poco noti. Possedevano nove libri, di cui i primi sei li bruciarono quando, dopo averli offerti tre per volta a Tarquinio il Superbo, verso il 520 AC, costui li rifiutò. Tarquinio, pentitosi del rifiuto, acquistò infine gli ultimi tre, al prezzo tuttavia di tutti e nove, stando a quanto scrive Aulo Gellio nelle Notti Attiche. I libri sibillini erano conservati in una camera sotto il tempio di Giove Palatino per essere consultati in occasioni speciali. Bruciati in un incendio del 83 AC, furono in parte ricostruiti da altre fonti, e conservati, secondo Svetonio, in due armadi dorati nel Tempio di Apollo Palatino per ordine di Augusto. Ricordiamo che Esdra, in 40 giorni insonni, con memoria perfetta stimolata forse da una certa pozione bevuta all’inizio, scrisse, dettandoli a cinque scribi, i libri sacri degli ebrei (o meglio, di quelli associati alla tribù di Giuda). Tali libri erano 94, di cui 24 costituiscono la Bibbia ebraica, riservata al popolo, mentre gli altri 70, più importanti (solo in questi si parla di immortalità dell’anima e del giudizio dopo la morte), erano lettura riservata ai sacerdoti (furono quindi ad esempio letti probabilmente da Zaccaria, marito di Elisabetta e padre di Giovanni il Battista). Questi 70 libri erano conservati in un armadio speciale di ferro nel Tempio. Quelli ancora esistenti, dopo la caduta di Gerusalemme nel 70, furono donati da Tito a Giuseppe Flavio.
Augusto fece raccogliere, per poi bruciarli, tutti i libri profetici che i suoi inviati trovarono nell’impero (similmente Paolo di Tarso bruciò i libri dei maghi dell’Anatolia, da lui sconfitti in una gara di magia). I libri sibillini scomparvero nel V secolo, forse bruciati, non si sa se tutti, da Stilicone nel 408. Ricordiamo che il governatore della Persia, nominato dai Mongoli, Ata Malik Al Juvaini fece bruciare nel 1257 i libri della biblioteca della fortezza ismaelita di Alamut, conquistata da Hulagu Kan. Alcuni ne conservò, dice nella sua storia della conquista mongola della Persia, ma quali tace.
Fra le profezie sibilline notevole è quella che fu letta nel 271 all’incoronazione dell’anziano imperatore Tacito, vedasi Ramella (2003): mille anni dopo Tacito sarebbe stato incoronato il più grande imperatore. Tutti pensarono ad una durata dell’impero romano di altri mille anni, non avvenuta. Alla Ramella sfugge che nel 1271 fu incoronato colui che può veramente essere considerato l’imperatore più grande noto, Khubilai Khan. Il suo dominio copriva quasi tutta l’Asia e parte dell’Europa, e fu un tempo di pace e di civiltà, stando a Marco Polo ed altri.
L’area sacra associata alla Sibilla a Cuma si sviluppa sotto terra, in un complesso di sale e camminamenti ancora ampiamente da esplorare, compito pericoloso per la presenza di gas velenosi e di facili crolli. La prima ampia esplorazione, ma solo del primo dei tre livelli su cui pare si estenda il complesso, è dovuta all’archeologo, filologo e studioso in vari campi, Robert Temple (2003). Temple è noto per avere collaborato con il medico Joseph Needham nel grande lavoro documentato da oltre 20 volumi dedicato alla storia della civiltà e della scienza cinese. Una sintesi di tale lavoro, curata da Temple, è libro di lettura obbligatoria nelle scuole secondarie cinesi, che ha molto contribuito al grande interesse dei giovani cinesi per la scienza e tecnologia; tale libro fa di Temple lo scrittore moderno più venduto al mondo.
Chi scrive ha proposto in più sedi, ovviamente inascoltato, che l’Italia, seguendo l’esempio dell’Indonesia con Borobodur, proponga un progetto Unesco pluriannuale, dal valore anche di oltre un miliardo dollari, per il recupero delle biblioteche certamente esistenti nelle ville di Ercolano, ora coperte dalle ceneri dell’eruzione del Vesuvio, dove sarebbero recuperabili molti libri ora perduti della classicità, e per creare un centro museale e di ricerca dedicato alle biblioteche perdute. A tale progetto potrebbe anche associarsi il recupero completo della zona sacra delle Sibille, con un simile museo sulla divinazione nei tempi antichi. Si ricordi che l’area napoletana è uno dei fulcri mondiali di civiltà e cultura, anche se oltre un secolo di pessima gestione ha rovinato quella che Casanova a fine Settecento definiva l’area più civile e bella d’Europa. Un’area di bellezze naturali e di cultura da recuperare.
Un secondo tema che nasce dalla geografia dell’inferno dantesco riguarda la stabilità della struttura. Il cono infernale occupa un dodicesimo della sfera terrestre, ricoperta da una parte della crosta. Al di là dell’aspetto di fantasia per un inferno nell’interno del pianeta, un problema interessante, e per quanto sappia questo autore, non completamente risolto, riguarda la stabilità di una sfera completamente o parzialmente cava, sia isolata nello spazio e quindi soggetta solo alla propria gravità, sia in interazione con campi gravitazionali esterni. Dall’esperienza quotidiana è chiaro che sfere abbastanza piccole di questo tipo esistono stabili. La questione riguarda sfere di dimensioni assai maggiori, anche astronomiche, ed è posta da alcune teorie apparse nella letteratura, fra cui:
- la teoria dell’astrofisico John Ackerman secondo cui Mercurio era originariamente il nucleo di Marte. Tale nucleo fu perduto in un complesso scenario astronomico di interazioni fra Terra e Marte, quando Marte per alcune migliaia di anni (fra circa il 7000 e il 750 AC) passò periodicamente (ogni 54 o 56 anni) assai vicino alla Terra. Teoria alternativa a quella ora più accettata a livello accademico, che vede Mercurio come il nucleo di un pianeta originario del sistema solare la cui crosta fu esòpulsa da un impatto tangenziale con un grande oggetto. Perso il nucleo, Marte potrebbe ora avere una parte centrale vuota, spiegando inter alia il fatto che la sua densità sia circa la metà di quella terrestre, sebbene il materiale superficiale sia simile a quello terrestre. Ovviamente questa teoria porta a molti problemi sulla dinamica dell’espulsione e sul successivo riposizionamento del materiale marziano.
- La proposta di Iosif Shklovsky, Fred Singer e Carl Sagan che i due satelliti Phobos e Deimos di Marte potrebbero essere cavi, e di origine artificiale. Proposta ben poco convenzionale, e coinvolgente un Sagan grande accusatore delle teorie di Immanuel Velikovsky, che seppe ben rispondere alle sue obiezioni in un convegno in università canadese.
Se possa esistere un pianeta cavo, impossibile eg secondo il fisico dell’Università Cattolica Giancarlo Cavalleri, e quali siano le condizioni di stabilità per una crosta di spessore d di un corpo di raggio R, è un problema non banale, su cui questo autore non ha fatto una ricerca esaustiva e lascia quindi aperto. Un primo approccio è stato tentato, senza risultato, alla ricerca di una formula semplice per la stabilità per un guscio omogeneo. I calcoli indicano che entrano in gioco in modo non banale la densità del corpo, la costante G di gravitazione, il raggio R e lo spessore d.
Tale problema ha attirato anche l’attenzione di Galileo, che ne considerò alcuni aspetti, in via non teorica ma sperimentale. Galileo, un genio sperimentale più che teorico, spesso usava esperimenti per risolvere problemi teorici. Famoso è il caso dell’area fra la curva della cicloide e la retta di scorrimento, che lui valutò sperimentalmente a tre volte l’area del cerchio generante la cicloide, un risultato provato poi teoricamente dal suo allievo Torricelli.
3. SULL’ALTEZZA DI LUCIFERO E ASSOCIATE QUESTIONI
Lucifero appare nelle tradizioni antiche in almeno due connotazioni. La prima è astronomica e lo associa alla stella del mattino, che appare prima del sorgere del Sole, Venere, che solo in tempi relativamente recenti fu scoperta corrispondere anche a Vespero, la stella della sera, che appare dopo il tramonto del Sole.
La seconda lo vede come capo di angeli che si ribellano a Dio per superbia, sono sconfitti e precipitati nell’inferno, dove Lucifero resta il loro capo. Lucifero è posto da Dante in fondo al cono che definisce l’Inferno, immerso per metà in una “ghiaccia”.
Galileo analizzando il testo dantesco ottiene di Lucifero la misura dell’altezza, in braccia fiorentine, corrispondenti a circa 1200 metri.
In uno dei lavori di questo autore, Spedicato (2016 a,b), si sono considerati, prevalentemente nel vasto mondo asiatico, numeri molto grandi, che appaiono inaccettabili, o incoerenti con altri numeri di simile significato. Tesi di Spedicato è che tali numeri siano stati crittati, il valore vero essendo un tabù, fatto frequente nel mondo antico (vedasi i nomi dei pianeti per i celti, i nomi dei monti per i mongoli, e lo stesso vero nome di Roma…). Semplice la tecnica di crittazione, ovvero la moltiplicazione del numero vero per 180, numero ben significativo come numero di giorni fra due successivi equinozi o solstizi, quando l’anno terrestre constava di 360 giorni, prima del diluvio noachide del 3161, come argomenta da vari autori (con riferimento a calendari egizi, sumeri, indiani, maya…).
L’origine asiatica degli ebrei è ben certa, anche se di solito, ed erroneamente, il loro capostipite Abramo è considerato un pastore semita proveniente della Mesopotamia (di Siria, come specificato nella Settanta), con riferimento alle città di Ur e Haran. Origine degli ebrei è invece assai probabilmente il Kashmir, dove pure esistono le città Uri (una variante alla persiana di Ur) e Haran. Scrivono Aristotele ed altri filosofi greci che “gli ebrei originano dai sapienti dell’India”. Il Kashmir è parte fondamentale dell’India, terra che è una vera Mesopotamia dai cinque fiumi (Uri è sul Jhelum, affluente dell’Indo, con portata simile a quella dell’Eufrate).
Come sia Dante arrivato a dare a Lucifero una altezza simile non sappiamo, ma le sue fonti solo parte sono note. In particolare non si può escludere che Dante fosse membro di un gruppo segreto che conservava antiche conoscenze degli iniziati ai Misteri Eleusini, vedi Bizzi (2017). In tali misteri giocava un ruolo importante una battaglia fra gli dei, associata ai quattro figli di Giapeto, dio antecedente Giove. Si noti la similitudine fra Japetus e Jupiter, e che l’attributo di Jovis Pluvius ben si accorda con l’origine della parola Jupiter come ibrido sanscrito-cinese, piter, padre, in sanscrito e ju = pioggia, in cinese. Che ibridi fra diverse lingue esistano, è certo, questo autore ne ha avuto conferma dal filologo Luigi Lehnus. Che ibridi esistano fra sanscrito-cinese è provato dal nome antico e veritiero della più alta montagna del nostro pianeta. Questa è vergognosamente chiamata Everest solo da un po’ più di un secolo, cambio di nome discusso nel libro Il bel Paese, di Antonio Stoppani. Il nome Everest fu dato dagli inglesi in onore del responsabile dell’Ufficio Topografico inglese in India, un funzionario assai amato anche come costruttore di alberghi sull’Himalaya dove sfuggire al caldo dell’estate indiana. Il nome antico, ben noto in India, è Gorishanta: Gori= bianca signora, in sanscrito, shan = montagna, to = grande, in cinese. Quindi bianca signora delle grandi montagne, nome sulla cui appropriatezza è ben difficile discutere. Vari gli ibridi fra turco e cinese sui monti Tien Shan, vedasi e.g. Maillart (2002).
Si può ipotizzare che Dante non abbia inventato l’altezza di Lucifero, ma l’abbia trovata in qualche memoria di lontana origine asiatica, e nella forma crittata descritta, senza sapere che era un numero crittato. Zecharia Sitchin, i cui libri hanno venduto oltre 100 milioni di copie, dichiara per Nibiru il periodo crittato di 3600 anni, mentre quello vero è da considerarsi di 20 anni, vedasi Spedicato (2016).
Dividendo 1200 per 180 otteniamo per l’altezza di Lucifero circa 6.7 metri, altezza certamente non raggiunta da nessun umano oggi o in tempi storici, dove forse il limite è sui 3 metri. L’uomo più alto in tempi recenti pare sia stato Robert Pershing Wadlow, di 2.72 m, morto nel 1940, vedasi Wikipedia; recentemente si è parlato di u vivente giovane ugandese che avrebbe quasi raggiunto i 3 metri, causa una disfunzione del sistema ghiandolare.
L’altezza di Lucifero suggerisce un confronto con le altezze di altri giganti nelle tradizioni antiche, in particolare nella Bibbia. Una lista parziale:
- Nel Libro di Enoch è scritto che i giganti dell’era prediluviana raggiungevano altezza di 2000 cubiti (ovviamente una stima approssimativa, forse un valore medio, e quindi implicante anche valori più alti). Assumendo l’uso del cubito reale di circa 52 cm, si avrebbe un’altezza oltre 1000 metri, vicina a quella in Dante per Lucifero, e corrispondente decrittata ad un 5.5 metri. Forse Dante conosceva tale libro (le copie odierne vengono dall’Etiopia e dai Balcani, al tempo erano forse anche in Italia …), da cui stimò l’altezza di Lucifero, che come capo poteva ben essere il più alto del gruppo?
- Golia, citato nel Libro delle Cronache, era alto 6 cubiti ed un palmo, circa 3.3 metri; Og, citato anche lui nelle Cronache, aveva un letto di 9 cubiti, e quindi forse una altezza superiore ai 4 metri.
Notiamo che anche Eracle era un gigante, la cui altezza fu calcolata da Pitagora, stando a Plutarco, ma il valore non è pervenuto. Pitagora usò il fatto che Eracle misurò la lunghezza dello stadio di Pisa (in Peloponneso, nella zona di Olimpia; migranti da questa città avrebbero poi fondato Pisa in Toscana) in termini dei suoi piedi. Anche vari sovrani bizantini erano di altezza molto superiore ai due metri, stando alle relative cronache; il Savoia re Carlo Alberto superava i de metri.
Chi cammini sul pianeta terra può avere problemi gravi se di grande statura, o più precisamente se un grande peso gravi sulle sue gambe. Come esiste per ogni pianeta un limite all’altezza possibile delle montagne (circa 10 km per il nostro pianeta), così esiste un limite al peso-altezza di un essere che cammini, dato dalla resistenza delle ossa delle gambe, su cui può gravare un peso massimo. Problema questo a lungo considerato un enigma per i dinosauri, che si riteneva potessero muoversi solo stando in acqua, dove l’effetto del peso è ridotto per la spinta archimedea. Il peso dipende dalla costante G, che è tuttora al centro di irrisolte problematiche. Non si può infatti escludere che G vari nel tempo e nello spazio (come è facile vedere se si accetta la teoria di Eulero e Le Sage per la gravità, quella nel cui ambito Olinto de Pretto (1903-1904) ricavò la legge E= mc2, poi anche in Einstein). Il fatto che Lucifero giaccia per una metà in ghiaccia (acqua con pezzi di ghiaccio, preferibile interpretazione a quella di ghiaccio solido) suggerisce che avesse un peso eccessivo per le sue gambe sotto la gravità terrestre, e quindi dovesse stare in acqua. Notiamo la presenza di simile essere acquatico nella tradizione sumera del dio Oannes, che viveva in acqua, venendo ogni tanto a riva per dare utili informazioni.
Quanto sopra apre scenari interpretativi nuovi in merito a Lucifero, e a tutto il mondo antediluviano, ivi comprendendo l’origine della civiltà umana non necessariamente per evoluzione autonoma. Scenari che per la loro complessità e difficoltà di analisi delle fonti, da ricercare in tutta la memoria umana del passato, non hanno spazio in questo articolo.
Bibliografia:
- Bizzi Nicola, Da Eleusi a Firenze: la trasmissione di una conoscenza segreta, Aurora Boreale, 2017
- De Pretto Olinto, Ipotesi dell’etere nella vita dell’universo, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, LXIII, 1903-1904
- Maillart Ella, Vagabonda nel Turkestan, EDT, 2002
- Ramella Ilaria, Cultura e religione etrusca nel mondo romano, Edizioni dell’Orso, 2003
- Spedicato Emilio, Grandi numeri nelle cronologie asiatiche: una chiave di lettura, Quaderni Asiatici 93, 2011
- Temple Robert, Netherworld, Random House, 2003
Autore: Emilio Spedicato




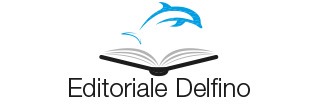

0 commenti